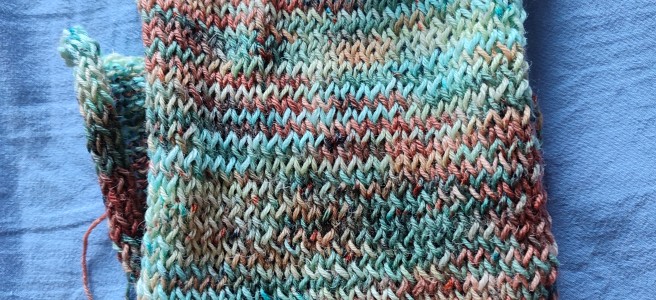Nove anni fa, più o meno in questi giorni, scrivevo questo post.
Avevano appena chiuso Friendfeed (se non sapete cosa fosse mi dispiace moltissimo per voi perché vuol dire che non lo avete vissuto e a mio parere avete perso qualcosa di bello che non è facilmente spiegabile a chi non c’era) e stava cominciando la diaspora di noi friendfeeders, o fifini, che ormai siamo diventati fufini (fufini perché fifi, che era l’acronimo nato dal FF logo della piattaforma, è stato trasformato in fufi, il fu funge da passato remoto, e in effetti quelli che eravamo allora sono diventati tutti fu, e non sempre è un male. A volte sì, ma quella roba è triste e ne parleremo altrove, se non ne abbiamo già parlato).
Ci aggiravamo tristi per la rete cercando un posto dove migrare, sembra un po’ una cosa biblica, tipo la fuga d’Egitto del popolo di Israele alla ricerca di una terra promessa. Vi svelo subito il finale: la terra promessa non esisteva. Quindi a un certo punto ci siamo fermati dove stavamo meno stretti.
Siamo andati avanti così, per qualche tempo, e intanto passavano gli anni, e in questi anni qualcuno interagiva ancora on line, qualcuno si incontrava, qualcuno non solo si incontrava ma cementava amicizie, facevamo ogni anno un raduno di amici immaginari (perché ci chiamiamo così, tra persone che si sono conosciute lì, io almeno li chiamo ancora gli amici immaginari, è meno complicato che spiegare dove e come ho conosciuto la maggior parte delle persone con cui ho discusso, riso, pianto, litigato in 13 anni della mia esistenza).
E poi a me è successo qualcosa.
Mentre il tempo passava e si trascorreva il tempo a celebrare un luogo on line che non esisteva più, io andavo avanti, e le mie amicizie di vecchia data si confondevano con quelle incontrate on line, si fondevano con quelle nuove, e non aveva più importanza il dove ci si era conosciuti, il perché, e il come soprattutto.
In questi 9 anni di assenza del socialino ho conosciuto molte delle persone dietro ai nick, e ho scoperto mondi che non avrei mai potuto conoscere altrimenti.
Ho trovato lavori. Ho fatto la babysitter ai bambini di quegli amici immaginari. Sono stata a un funerale e altri ne ho mancati, sempre di quegli amici.
Ho scoperto il femminismo. Ho pubblicato un romanzo grazie anche a quegli amici.
E soprattutto mi sono accorta che nonostante friendfeed non esista più come luogo è rimasto uno spirito della sua comunità, che si presenta nei momenti peggiori.
Da quelle persone conosciute on line, che a volte ho frequentato e a volte no, sono usciti gesti che somigliano alla solidarietà tipica delle comunità di un tempo.
In questi giorni è successo di nuovo, e la cosa straordinaria è che appena si chiede aiuto l’aiuto arriva, come se non fossero mai passati 9 anni, come se il fatto che non esista più il luogo fisico dove ci incontravamo a tutte le ore del giorno e per qualcuno della notte (non per me che vado a dormire con le galline) in fondo non sia rilevante, perché lo spirito del friendfeed non è mai stato spento.
Quindi per la prima volta in nove anni io non mi sono commossa leggendo i post nostalgici di chi faceva parte di quella comunità.
So perfettamente che friendfeed non è morto, ma è solo cresciuto, perché friendfeed era fatto di persone che si sono incontrate in un certo momento della loro vita, si sono piaciute e per qualche strana ragione continuano a piacersi ancora adesso, anche se non hanno più una casa e non si leggono più tutti i giorni.
Sapete quando i bruchi diventano farfalle? Ecco.
(ed ecco perché ho smesso di commuovermi intorno al 9 aprile, ma sono contenta di essere diventata grande anche grazie a un sacco di quelle persone da cui ho imparato che il modo migliore di crescere è sempre avere intorno persone migliori di te, per cultura, per indole e per qualsiasi cosa che mi venga in mente. Altrimenti resti per strada, e nessuno dovrebbe restare per strada)